fotografia di WildOne da pixabay
Ivan Fedeli, La buona educazione, puntoacapo, 2021

Leggere ogni nuovo libro di Ivan Fedeli significa farsi guidare da uno sguardo attento sul mondo, sgravare gli occhi dal peso che ci limita lo sguardo, la barriera che ci impedisce di fissare oltre la linea dell’orizzonte la vita che ci appartiene. Anche in questo libro Ivan Fedeli sa restituirci alla nostra dimensione di uomini, al valore delle piccole cose, degli eventi minimi e apparentemente ordinari che costellano le vite di ciascuno di noi (“capisci del mondo e intendi che sono / in fondo le cose piccole a farlo / girare, i dettagli a renderci vivi”), focalizzando questa volta la sua (e nostra) attenzione sul tema dell’infanzia, quegli anni lontani della nostra esistenza dove tutto accade in modo più spontaneo, sincero, ma dai quali “si cresce a strappi a volte / e troppo in fretta forse”. E ci conduce in questo viaggio con quella limpidezza di contenuti e di stile a cui ci ha abituato, con il suo endecasillabo narrativo e lirico insieme, dagli enjambement forti e circostanziati, dalla colloquialità dimessa che sa bene nascondere il rigore di una ricerca e di una precisione della parola, quelle che ha esercitato e fatto evolvere con coerenza e sempre maggiore perizia di opera in opera. La tensione e la concentrazione della sua dizione poetica si mantengono alte lungo tutto il percorso del libro: assistiamo certamente a un recupero memoriale che molto deve all’esperienza privata dell’autore (che non manca di offrire ritratti sempre molto vivi e coinvolgenti dei compagni, piccoli come lui o adulti, che hanno animato quegli anni: ritratti che sono un suo marchio di fabbrica distintivo) ma il merito, ben noto da tempo, di Ivan Fedeli sta nella sua capacità di rendere l’immedesimazione del lettore credibile, trasformare queste storie personali in “exempla”, mai retorici, che sono in definitiva specchi in cui è possibile per il lettore riconoscersi, leggere anche le sue, di storie, perché ciò che conta davvero nella vita, in definitiva, è comune a tutti. Detto con le parole di Mauro Ferrari, le poesie di Fedeli “attingono allo stesso serbatoio umano che tutti condividiamo”.
Che cosa resta allora di quegli anni? Che cosa dura nell’uomo adulto di quel bambino o di quel ragazzo che l’hanno preceduto, dalle cui ceneri è nato l’uomo di oggi? In apertura alla silloge ci dice Fedeli, con voce disillusa: “O forse tutto è stato dato fatto / chiuso nell’esattezza di un cerchio e / dentro noi il resto ora manchevole ora / irrimediabilmente opaco perso”, anche se tutto il procedere della raccolta sembra, in verità, indicarci la necessità, l’indispensabilità di quelle esperienze, che restano a segnarci indelebilmente; la loro verità torna sempre a bussare alle nostre porte, perché “sono le cose / del tempo queste che non sai se tornano / in sogno o accadono semplicemente”. Fedeli ci porta per mano attraverso quegli anni settanta, in cui avvengono le sue storie, con evidenti riferimenti al contesto storico e culturale di quei tempi (da Pasolini a Rivera, da Pulici alle signorine buonasera, dalla Berté alle figurine Panini, dai Bee Gees a Mike Bongiorno), nell’idea che proprio allora “ardeva / una felicità buona”, e compito della poesia è riportarla alla luce, perché “servono parole /a esorcizzare il buio”, a restituirci nella dimensione di una speranza che non abiura, che tanto più è necessaria in questi tempi recenti che ci appartengono: così è possibile riappropriarsi di “quel futuro di cui / si parla a voce bassa, per timore / forse di sciuparlo troppo, abusarne”. In quelle esperienze ingenue e un po’ scapestrate (dai tiri in porta in campetti improvvisati di periferia al gioco del “tu ce l’hai”, dal “tana libera tutti” allo scherzo dei campanelli suonati a casaccio, dalla fata turchina di Pinocchio alla paura per l’uomo nero, da Peter Pan a Tex Willer) risiede il seme di “giorni invincibili, giorni di un tempo /che non servono freni”, giorni che occorre dire, che fa bene dire. Soprattutto oggi, soprattutto ora. O, detto magistralmente con i versi di Fedeli, compito della poesia è “sillabare gli anni / quasi fosse ieri l’eternità /e noi a rincorrerla finché la prendi”, perché non ci scappi, ancora e per sempre, forse.
Nella chiusa alla raccolta Fedeli si (e ci) domanda: “Ci perdoneranno per questo, il film / dopo carosello le barzellette / sconce i lanci di miccette a scuola?”, e pensando al futuro dice ancora: “Ma i grandi chissà, forse / pensarli come si fa quando dicono / dell’anima che non muore mai e va / da qualche parte ma non si sa dove / lasciarli al tempo che sarà prima / o poi.”, a ricordarci che nulla in realtà ci abbandona, tutto si deposita e si riplasma, riscrivendosi giorno dopo giorno: questi frammenti di un vissuto apparentemente negletto e vile sono le “cose / della vita da tenere ben care”, cose che Ivan Fedeli sa tradurre in versi, con efficacia, con credibilità, come tutto il suo percorso poetico ci ha dimostrato e ci dimostra ancora oggi. In fondo, questo è fare veramente poesia, e “così raccontano accada l’amore”.
***
Mariella Bettarini, Haiku alfabetici, Il ramo e la foglia 2021

Saluto questa casa editrice di Roma, appena nata, augurandole buon viaggio. Roberto Maggiani e Giuliano Brenna che ne sono i fondatori introducono il loro progetto editoriale con questa frase di Antoni Gaudì
Volete sapere dove ho trovato la mia ispirazione? In un albero; l’albero sostiene i grossi rami, questi i rami più piccoli e i rametti sostengono le foglie. E ogni singola parte cresce armoniosa, magnifica.
Sanciscono in questo modo un impegno, una responsabilità, un’annunciazione di tensione sia per gli autori che per i lettori.
Ospitare Bettarini è riconoscere il suo lavoro intenso e appassionato tessuto per l’intera vita, sia come poeta, saggista, traduttrice, che come editrice per le edizioni Gazebo, curata fino al 2016 assieme a Gabriella Maleti. L’opera è dedicata amorevolmente alla stessa Gabriella Maleti.
Il titolo dichiara immediatamente la ricerca artistica di Bettarini che, nel ritmo dell’alfabeto, raggiunge essenzialità e minimi arpeggi sulla propria corda esistenziale. Seppure amareggiata e resa estremamente sottile, tanta la sua sensibilità consapevole, mantiene garbo, ironia, e una sporgenza epifanica spaesante e spaesata. Il canto rimbalza delicatamente su una lirica giocosità linguistica, spesso sospesa da interrogativi, mai conclusa dalla definitività del punto.
Mariella Bettarini sceglie Pier Paolo Pasolini da Le Ceneri di Gramsci, posto a cardine e soglia delle sue poesie. A lui dedicò due suoi saggi.
I disegni di Graziano Dei e la postfazione di Annamaria Vanalesti completano.
Da voi riprendo
dolcissimi animali
da voi riprendo
***
Anita Piscazzi e Michel Godard, ferma l’ali, desuonatori, 2020

Si presenta nella forma di un libretto d’arte dalla grafica molto curata, rilegato a mano con uno spago, e accoglie al suo interno una raccolta di poesie di Anita Piscazzi e un CD con musiche di Michel Godard e voce recitante della stessa Anita Piscazzi: si tratta di un interessante lavoro in cui musica e poesia si combinano in un’ottima armonia, in cui nessuna delle due prevarica sull’altra; anzi le due componenti si danno forza, in un disegno d’insieme coinvolgente e ben orchestrato.
Anita Piscazzi ci aveva abituato fin dal suo lavoro “Maremàje” (Campanotto, 2012) a un’evidente attenzione verso l’oralità e le lingue minoritarie che la esprimono: qui il percorso si compie grazie alla collaborazione con Michel Godard che, oltre alla composizione delle musiche, le interpreta con basso elettrico e serpent SBergen, strumento quest’ultimo che dà un sapore onirico e mistico all’esecuzione che bene si sposa con il tratto, decisamente orfico, della poesia della Piscazzi (e, non a caso, “Il sogno del serpente” è anche il titolo di uno dei brani presenti nella raccolta). La parola di Anita Piscazzi, interpretata con un timbro caldo e corposo, a tratti sognante, a tratti oracolare, grazie alla dosatura attenta delle pause e dell’intonazione, rende con efficacia la sostanza dei suoi versi, intrisi di spiritualità e mistica (si veda anche il riferimento a Umiliana de’ Cerchi, mistica medievale fiorentina a cui è dedicato il testo eponimo), ma anche di quella sensualità tutta mediterranea dell’autrice che è fortemente radicata alle sue radici salentine, a quella regione crogiolo di culture e luogo dell’incontro fra civiltà e diversità in dialogo costante fra di loro. La combinazione fra musica e versi riesce bene anche grazie alla solida formazione musicale dell’autrice, diplomata in pianoforte al conservatorio e studiosa di storia della musica, basi solide che testimoniano come questo non sia un esperimento fine a sé stesso, ma il risultato di un percorso coerente e maturato con consapevolezza.
Ascoltando i brani dell’opera, rileggendo nel silenzio i versi, si ha davvero la sensazione di essere attraversati dal “basso continuo del mondo”; si vengono a creare sollecitazioni sonore, riverberi che si insinuano profondamente nel lettore e nell’ascoltatore, consentendogli credibilmente l’immersione in questo mondo che oscilla fra sogno e oracolo, grazia e senso della perdita, amore e disillusione, dove l’autrice dichiara: “ti porterò dove tutto è poco”. Fra i dodici brani proposti, davvero tutti riusciti, ci ha colpito in particolare “Cucimi gli occhi”, che già conoscevamo come poesia, interpretata dalla Piscazzi combinando alla recitazione il canto di una nenia in sottofondo: il risultato è un testo ipnotico e incalzante, che sa davvero condurre “dove le scarpe non hanno piedi e / il tremore dell’orecchio attacca / il nervo”, ai confini di una parola che si dichiara senza mai svelarsi del tutto, conquista e spossessa (“e io non so più nulla di me”, direbbe l’autrice).
***
AA.VV., Terra Mater, La natura, la bellezza, la vita, A cura di Nicoletta Di Gregorio con Prefazione di Nicola Mattoscio, 2020 Fondazione PESCARABRUZZO-IANIERI EDIZIONI
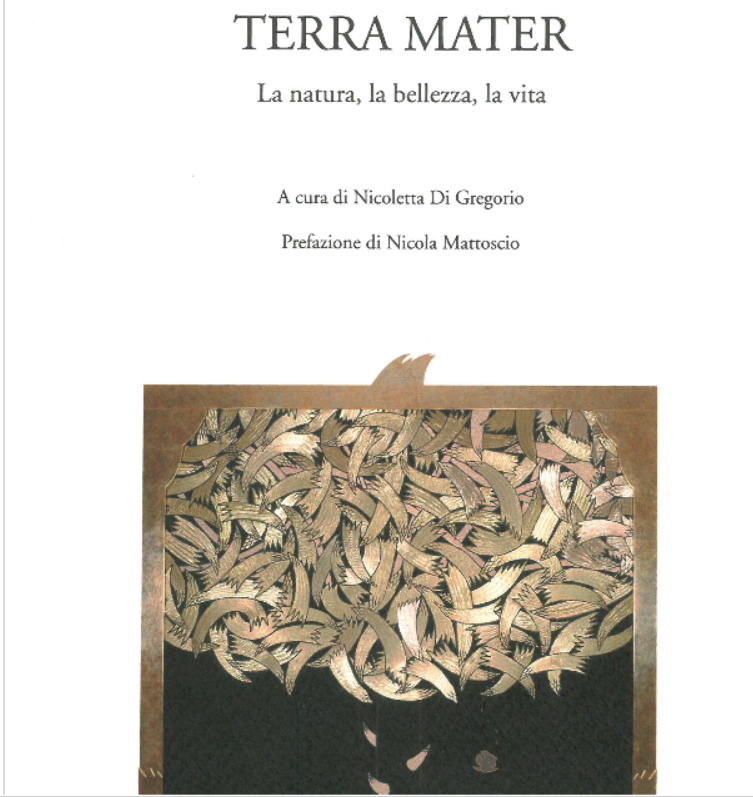
Nicoletta Di Gregorio ci introduce in questo mosaico lirico dichiarando immediatamente la centralità tematica dell’opera a cui tutti gli autori e le autrici hanno convogliato la loro espressione poetica, ciascuna nella propria personalità: è stato un contributo per riconsiderare il rapporto profondo e ancestrale con il creato, contro un processo di degrado culturale e ecologico.
Un rinnovato equilibrio e rispetto tra l’uomo e l’ambiente può diventare un’opportunità per rivedere i modelli culturali, privilegiando la dimensione dell’ ”essere” sull’ “avere”.
Possono bastare queste coordinate, per apprezzare l’intenzionalità dell’opera e l’impegno che Di Gregorio continua dopo tanti anni a portare avanti, sempre nella tensione del canto. Le poesie inedite e edite si incastonano l’una nell’altra, in una collana di poeti e poete noti, ritratti ognuno in una finale bibliografia.
L’opera ha veste tipografica pregevole, una cura elegante e attenta alla carta e alle quattro riproduzioni interne, più la copertina a colori di Sandro Visca, lavorate con stoffe cucite su cartoncino, in connessione alla tematica dell’Antologia.
Marjia BecKović, poeta serbo cirillico, chiude il tappeto delle 78 poesie.
Ricordo che nel 2015, la stessa Di Gregorio curò per la stessa Fondazione, un’altra antologia poetica di affine qualità, scelta per l’Esposizione Universale di Milano, dal titolo “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. L’opera corale era dedicata al tema della sostenibilità e del diritto all’alimentazione per tutti gli abitanti della Terra.
In questa intensa continuità bellezza e impegno civile si innestano, offrendosi.
***
Maria Luisa Bompani, Noi viaggiamo vicino, Incontri editore, Sassuolo (MO), 2020

Questo testo non “guida né traccia itinerari del cuore. Fa quello che può, e anche quello che vuole, cioè poco rumore, pochi chilometri, poche parole, poche illustrazioni”. Le descrizioni sono scarse e scarne, eccetto forse per i presepi, perché “come si fa coi presepi? Finiscono in scatoloni, cantine, nessuno li vede più dopo gennaio, stanno morti e magari si buttano come carta straccia. E allora li stampo nelle righe (…) non ci si può accontentare di presepi-mandala colorati e soffiarli via, bisogna registrare le nascite di tutti quei bambini di paglia, di sughero, di lana e lasciarli andare solo quando hanno il loro bel certificato, col timbro delle parole che si sperano vere.”. I paesi, anche se piccolissimi e camminati in lungo e in largo, non sono mai raccontati completi: una casa, una trattoria, qualche paesano, bimbo, gatto, quasi mai lo scorcio o il pezzetto che sarebbe l’attrattiva, pur da poco, per il turista; “alla ricerca di che”, quindi? “Dico senza convinzione a una mia amica che è più facile trovare cose vere lì che in luoghi più grandi e noti. Ma chi lo sa.”. I protagonisti di questo viaggiare “vicino”, per l’Appennino dietro casa, sono il Qubo a metano, Franco, il compagno dallo “sguardo sommario, panoramico” che “non guarda intorno più di quel tanto (…) con occhiate qua e là”, ma senza indugiare mai, e che le poche parole le spara in dialetto, quasi sempre con una magistrale capacità di sintesi ironica, saldamente ancorata a terra; infine lei, la scrivente, che, tra cataratta e “dolore alla schiena, peso, pigrizia”, a volte deve dividersi dal “corpo-me”, salvo poi riconciliarsi per ostinarsi con lui “a trovare il ricco e il molto presenti in un centimetro quadrato”. Lei cerca il “presente, dentro e fuori di me”, e vuole salvare un “gruppetto” di paesini che “non è di pietra”, ma fa parte della sua interiorità. Perché, si dice, forse lei ha “una struttura interiore a paesini”, come se “le molte anime di me” volessero “un po’ di case attorno, e gente che ti conosce, ospitale o quanto basta gentile. (…) In verità ci parliamo poco, come gli unici abitanti di case lontane chilometri l’una dall’altra. Non facciamo località, casa bruciata, case nuove, ca’ del sole o che so io, facciamo case diroccate isolate e siccome sono anni che ci parliamo con piccioni riottosi, con missive che arrivano dopo mesi, con sms bloccati dal gestore (…) ecco, adesso ci pensiamo ognuna col proprio paesino.”. Una volta le capita di incontrare a Minozzo la casa che le assomiglia proprio: “piccola”, “due porte malconce (…) disabitata, con persiane chiuse e rattoppate”, scrostata, strizzata tra altre case più moderne ai lati e dietro. Franco scappa, perché chi dice così, micca ha le rotelline del cervello a posto, temendo addirittura qualche tentazione di acquisto-restauro. Ma lei lo sa che “la casa-me” non può essere restaurata da “dottori e muratori”, che è destinata al “doloroso essere esposta agli eventi, allo sguardo della piccola comunità cui appartieni.”; e che, quindi, è meglio “vivere separate, io nel suo prezioso ricordo e lei almeno alleggerita dal peso di avere addosso (…) anche un’anziana fuori di testa”. In quanto a Franco, sempre recuperato poco più in là, basta cercare di tenerlo “al guinzaglio corto”. Potrebbe allora questo libro indurre a pensare ad un testo che fa di quel viaggiare solo la scusante per un itinerario tutto interiore? No. Innanzitutto perché i fotogrammi isolati che la scrittrice ci dà dei paesi incontrati sono “veri”. Cosa può significare: “veri”? “Ma provate a trovare una cosa vera.”, ci anticipa all’obiezione la scrittrice. Poi ci butta, non a risposta ma quasi a scavo di domanda, una manciata di riflessioni complessissime e – mi si permetta – “vere”: “Ciò che è bellissimo se vissuto intimamente diventa osceno nel senso etimologico se guardato da fuori, e visto ovunque.”. E con la visionarietà dei social, non si salva neanche la fotografia, l’arte, la scrittura. Come se guastassero, invece di evidenziarlo, il bello. Lei non rinuncia a scriverne, delle “cose belle, e anche quelle così così”, “un po’ di parole, ogni tanto”. Spesso dubitose, dette e poi rimangiate, mai apodittiche. A volte per segnare un ‘non detto’, un ‘tralasciato’. Quello che, però, dei paesi tralascia, la scrittrice è come se poi ce lo proponesse in un magico spazio vuoto, incontaminato dalla retorica, senza eccessi di ‘borgomania’ più o meno poetici, anche senza eccessi di ‘bello’, più attinente ad una normalità che, pur essendo nostra quotidianità, sempre più ci appare insostenibile, da rifiutare, peccaminosa, insignificante. Uno spazio vuoto che non esclude, ma invita ad andare. Piano, quasi a caso, senza aspettarsi il ‘caratteristico’ o l’‘incontaminato’, insomma senza nessuna rivelazione, anzi, ad un certo punto, immaginando il giro proprio attorno attorno a casa, dal salotto al cortile, al marciapiede che non c’è, al giardino, fino, massimo, alla casa del vicino. E non è un itinerario tutto suo, della scrittrice, perché, se già i paesini interiori, pur a “colombi riottosi”, riescono a dialogare tra loro, così pure si aprono ad un rapporto, di nuovo: “vero”, anche se fatto di poche e apparentemente banali parole, con quelli che incontra: quasi mai sono dialoghi da massimi sistemi, quasi mai incontra motti o frasi degni di immortalità, eppure il sapore che ci rimane negli orecchi è quello di un contatto “vero”, e ci sembra di esserci stati noi, là, in quella trattoria, davanti a quella chiesa, con quei novantenni. E allora, altro che chiusura interiore contemplativa: la scrivente si allunga un po’ di più, ci tocca col suo corpo – che è dolorante, a volte, sì, lo sentiamo, e a volte scontroso, ma anche vogliosissimo, quando sogna il buffet che il paese offrirà dopo la festa e attentissimo alle minime adiacenze che mettono in contatto, così che ci lascia completare quel suo sguardo offuscato dalla nebbia della cataratta, ci porta con sé anche noi, ‘davvero’. Noi, che se non siamo proprio il massimo desiderabile o compatibile con le sue priorità, noi però ci riconosciamo: siamo come Franco, “una grazia non richiesta ma esaudita dal profondo”, che non cerca quello che cerca lei, che “soprattutto non ne farà parola. (…)un ladro buono di bellezze che non vuole nessuno.”, con cui essere insieme in “qualche sparuta osteria” che sia testimonianza della “bontà dello stare insieme”, appunto: “a gustare, a tenere acceso il camino di un noi difficile per me”.
Lo stile, originale e sapientissimo, nasconde la perfezione linguistica in un’apparente modalità del parlato, che non vuole certo fingere un proporsi popolareggiante da parte di chi scrive, ma piuttosto rinviare ad una dimensione così intima e così profonda da non potere essere espressa né con una concettuosa lingua alta, né con un’astrazione dalla completezza del corpo-mente. Che magnificamente rende i paesini interiori affacciati ai paesini dell’Appennino, ma soprattutto affacciati a noi lettori. Particolarmente interessante poi la nota narrativa che nella nebulosità della cataratta della protagonista cela e motiva due elementi fondamentali delle scelte testuali: l’imprecisione visuale, infatti, che in certi casi di scarsa luminosità diventa vera e propria assenza di visione, sostiene quasi causalmente la sottrazione di tanta parte dei paesini attraversati, anche se poi è evidente che invece rientra in una precisa scelta narrativa, ma non certo soltanto, dell’autrice. Inoltre la scarsa adesione ai contorni visivi della cosiddetta realtà, quella nebulosità che mentre sottrae permette invece la ricreazione dell’arte, la rilettura del mondo, è come una personificazione –tanto tanto corporea – del processo stesso artistico, tanto più interessante quanto più disvelta dai mitici canoni intellettualistici o spirituali o orfici di cui l’arte ha amato ed ama ammantarsi.
***
Anterem, Rivista di poesia e scritture di ricerca, Fondata nel 1976, n.100 VII serie Anno 45
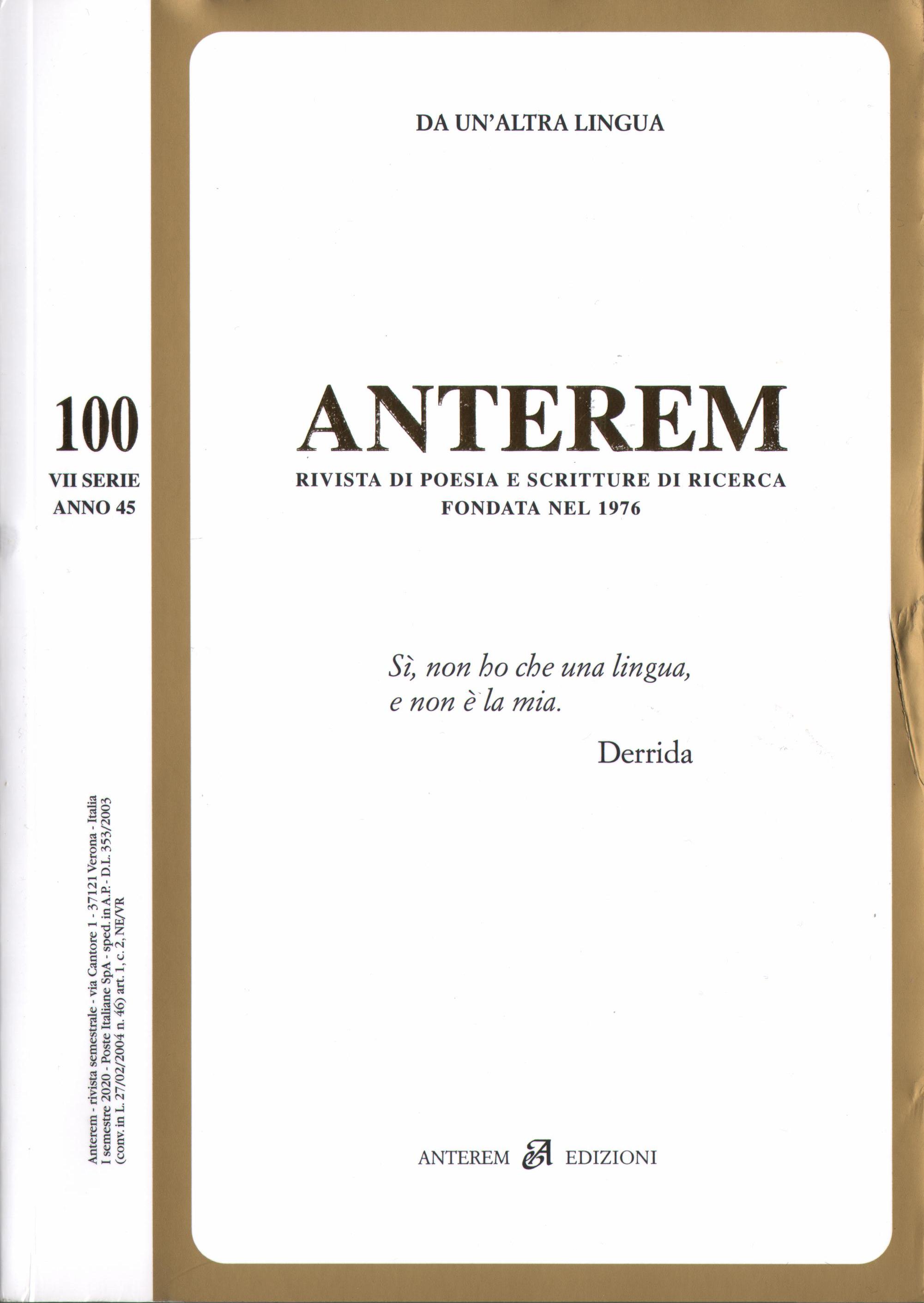
Ci ricorderemo per sempre di questo n.100 aureo di Anterem. Per la sua pregnante bellezza, per il gesto che compie verso il lavoro paziente e certosino agito su una scelta lavorata, pensata, esposta nella traduzione come ponte culturale e linguistico tra i mondi nella consacrazione del canto.
E’ l’ultimo numero. Ma nella poesia vige il significato del divenire, di una non mai definitività. Apprendiamo dalla redazione che:
Con grande dispiacere e con un sentimento di forte passione, gratitudine e rispetto per la sua storia, comunichiamo che, dopo l’uscita del numero 100, la rivista “Anterem”, fondata e guidata per 45 anni da Flavio Ermini con idee, visione e coraggio, interrompe la pubblicazione.
La decisione del nostro direttore è stata sofferta e ponderata. Ha scritto alla redazione: “Devo dirvi con rammarico che questo numero cento sarà l’ultimo. La rivista Anterem con questo numero, al massimo dello splendore, cessa le sue pubblicazioni. Rimane a voi il compito di proseguire la restante attività da ora in poi, e se lo vorrete”.
Con lo stesso rammarico, dobbiamo comunicare che è di conseguenza sospeso, già dall’edizione 2019/2020, il Premio Opera prima, ideato con Ida Travi e da lui interamente gestito per vent’anni.
Possiamo annunciare che il patrimonio di esperienza e conoscenza che “Anterem” rappresenta non andrà perduto: sarà interamente riversato, in accordo con Flavio, nell’attività della nuova casa editrice, che proseguirà con rinnovati progetti per le diverse, storiche, collane.
È stato inoltre potenziato il Premio Lorenzo Montano e tutto quello che gli gravita intorno, a partire da Carte nel vento, grazie al già comunicato ingresso in giuria di Silvia Comoglio, Stefano Guglielmin, Maria Grazia Insinga. Come da prassi consolidata, sono ex vincitori, nonché “Autori di Anterem”.
Questi tre poeti e critici si sono aggiunti a Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Mara Cini, Ranieri Teti.
Flavio Ermini rimarrà presidente onorario dell’Associazione di promozione sociale Anterem, da cui tutto origina.
Nel cambiamento restano la continuità di intenti e l’idea di ricerca condivisa nella grande comunità cui “Anterem” ha dato vita.
Dopo l’editoriale del direttore Flavio Erminio, l’antologia spalanca, nello splendore di due pagine alla volta, una poesia in frontespizio e la sua traduzione, firmata da una mano maestra. Dal 1976 al 2020, numero per numero, creando un ventaglio internazionale di versi che fluisce nella nostra lingua.
In copertina Derrida:
Sì, non ho che una lingua,
e non è la mia.
***
Vanni Schiavoni, Quaderno croato, Fallone Editore, 2020

Colpisce fin dalla sua prima lettura questa silloge, così compatta e ben costruita, pubblicata dall’Editore Fallone, da sempre orientato a scelte di qualità e coraggioso nelle sue proposte. La silloge si inserisce nel genere della letteratura di viaggio in versi, del baedeker in versi, se preferite, riuscendo però a sovvertire rigidità e schematismi che il genere comporterebbe. Si tratta di una breve silloge di dodici poesie, strutturate in realtà in sei coppie, corrispondenti a sei località per ciascuna delle quali compare prima una poesia con il nome in italiano del luogo e poi una seconda con il nome in croato; si origina così un rapporto di canto e di controcanto, capace di rappresentare la realtà del luogo da una duplice prospettiva: prima quella del turista incuriosito dal fascino e dalla bellezza, se non dalla singolarità, del luogo (“più gli aggettivi non bastano allo stupore”); poi quella più nascosta e tragica del luogo in cui ancora restano le tracce della guerra che ha attraversato il Paese, devastandolo con morti e distruzioni, segni o lacerti di un passato che condensa “in strappi la memoria”.
La parola poetica di Schiavoni, che dedica la raccolta “al mio cognome” proprio a sottolineare come in noi si deposita e si rivitalizza la radice a cui apparteniamo, genera quindi un processo interessante di intersezioni, di letture sovrapposte in un quaderno che nasce certamente da un viaggio, ma è soprattutto un percorso interiore attraverso la storia dei luoghi, quella che non si dimentica, che lascia cicatrici indelebili, comprensibili pienamente solo da chi le ha vissute sulla sua carne: “perché per sempre saremo bambini / sotto i bombardamenti di Baghdad / siamo ancora ragazzini tra le granate di Mostar”, versi questi in cui si superano le distanze geografiche dei luoghi, perché la guerra è un male identico ovunque, semina solo odio e dolore, anche quando la si maschera come “guerra patriottica”. Ecco allora che anche la mitezza, l’imperturbabilità del paesaggio, fossero anche gli splendidi laghi di Plitvice, che “piovono così / eterni / perfettamente indenni”, non possono rimuovere la consapevolezza de “la notte che arriva puntuale”, il “presagio necessario nella retina segnata / dalle schegge dell’ultima scossa”; anche fra le bellezze architettoniche delle città si insinuano dettagli inquietanti come “i campanili conficcati come picche in attesa di teste”, “gli angeli ammazzadraghi” che sorvegliano gli uomini “sempre predatori, costantemente prede”. Paesaggio e interiorità si combinano e si contaminano, creando una poesia plasticamente intensa, ricca di implicazioni, mai scontata, capace di fondere dettaglio visivo e riflessione esistenziale, come in questo distico così efficace: “L’aria sul muro di cinta rifrange / i flutti di vita sul lato dei pianti”.
La lingua di Schiavoni è articolata e densa, impiega anche alcuni preziosismi (come “liliale”, “acheropita”), con costruzioni ampie e spesso ipotattiche: l’esatto contrario del minimalismo e dell’ellissi; ne nasce quindi una narrazione in versi, però mai cronachistica, innervata come sa essere di spinte improvvise, scorci inattesi, balzi semantici. Il senso è quello di un mondo che ci attraversa, entra “nelle ossa come fossero tasche” e a chi viene visitato dalla poesia non resta se non trascrivere ciò che “la memoria della specie conferma”, esserne “punto focale”, “raccogliere tutto”.
****
Simone Marchesi e Roberto Abbiati, A proposito di Dante, Keller, 2020

Settecento anni dalla morte di Dante. Cominciano a fiorire saggi, riletture, nuove edizioni e tanto contributo sarà prezioso a leggere e ritrovare.
Vorrei fermarmi su un volume uscito alla fine dello scorso anno, A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia, pubblicato da Keller. Gli autori sono Simone Marchesi, un italianista, specializzato nella letteratura delle origini, professore a Princeton e Roberto Abbiati, attore, disegnatore, musicista, mimo… Cento i canti della Commedia e duecento le pagine di questo libro: Il testo di una terzina da ogni canto con una breve densa e originale riflessione e, a fronte, un disegno in nero coi tratti di una penna che non si stacca dalla pagina e gira fino a costruire suggestioni e profondità. Sulle prime spiazzante… poi andiamo a cercare aiuto nella pagina finale, “Ringraziamenti in forma di note”, e scopriamo che da quella terzina, scelta dal professore, si producono nel disegnatore collegamenti e allusioni che attingono a un sapere ampio e variegato: De Gregori e Aldo Manuzio, Julia Bolton Holloway e Agostino, Leonardo e Rauschenberg, Saint-Exupéry e gli Yoga Sutra di Patañjali…
Regalo questo libro alla mia nipotina che compie otto anni, vive in Germania, e due anni fa ha felicemente imparato L’Infinito di Leopardi. Vorrei che avesse per lei la stessa forza immaginifica dei racconti orali dai quali ho conosciuto, bambina, la Commedia; certo non mi furono insegnati la metrica o il commento critico, e anche la riproduzione a memoria del testo dantesco era piuttosto approssimativa, ma la forza di quel racconto, a scuola poi, ha prodotto un riconoscimento incantato, un pescare nella storia personale che carica il fascino della lettura di un sedimento emotivo e lo trasforma in piacere.
Pezzetti di poesia, quasi a caso, su un libro che bisogna tenere sulle ginocchia perché è grande, per lasciare spazio al disegno, e consentire quel tratto di riflessione che si genera sulla sosta.

