foto di WildOne da pixabay
Renzo Franzini, Come in dittici antichi autentici, Del poetico in Lorenzo Calogero, Macabor, 2021
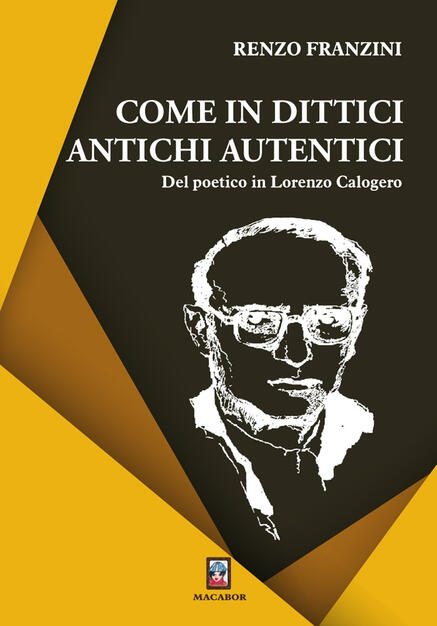
Ho desiderato molto che questo saggio venisse alla luce, sia per l’immenso, serissimo, lavoro certosino di Renzo Franzini, sia per rimettere in attenzione Lorenzo Calogero che, per infiniti motivi, né in vita né postumo, ha avuto giustizia della sua eccellente qualità.
Infiniti motivi: uno dei quali l’essere al di là del consueto, del canone, scompaginando la grammatica, in un’originalità che impone assoluta lentezza nell’incontro. Inoltre, il suo essere ipersensibile, fragilissimo, disposto totalmente alla poesia, all’assoluto del sentire e del canto.
Proprio per questi, tra molti altri motivi, Calogero, e come lui tanti altri poeti nel nostro Paese, hanno subito e continuano a soffrire di un vero e proprio esilio da una giusta legittimazione del sistema letterario. Non se ne parla, non si compiono approfondimenti, studi, rimangono oscurati gli inediti. Non è un caso che siano quei pochissimi, eroici, poeti affini, vocati drammaticamente alla stessa purezza, che riprendono il testimone con cura amorosa, certosina. Come Renzo Franzini che ha lavorato anni e anni la sua meditazione su Calogero. Così come va riconosciuto a Bonifacio Vincenzi la volontà tenace di portare spesso in Macabor i luoghi profondi e meno illuminati della poesia italiana, anche accogliendo nel proprio catalogo quest’opera.
Ricordo “Mappale dei cammini” di Renzo Franzini, che pubblicai nel 2017, nella mia collanina in Lietocolle. Ricordo l’impatto folgorante che ebbi con una poesia dalle maglie strettissime, esigenti, di imprevedibili curvature dentro cui un lavoro microscopico su ogni cellula linguistica. Questo per confermare, secondo me, il ponte interiore tra Calogero e Franzini.
Lorenzo Calogero nasce in un paesino in provincia di Reggio Calabria nel 1910. Si laurea in Medicina, svolgendo la sua attività di medico condotto con tutta la difficoltà per la propria, estrema fragilità psichica, accentuata dalla morte dell’adorata madre. La sua solitudine, internata più volte, affondata anche dal silenzio della critica italiana, fu interrotta dal suo volontario congedo nel 1961. Leonardo Sinisgalli fu tra quei pochi che credettero nei suoi versi.
Eugenio Montale sul Corriere della Sera scrisse questo celebre commento sull’opera di Calogero: “Accostarsi alla sua poesia è un’ardua impresa perché in lui la parola è del tutto spogliata del suo contenuto semantico e ridotta a semplice segno(…). Fu dotato di uno reale temperamento poetico ed è quindi da escludersi un abbaglio da parte di coloro che oggi vogliono rendergli l’onore che gli fu negato in vita. Calogero ha lavorato per molti anni in un incrocio di tendenze, rifiutandole tutte per non impoverirsi, interamente posseduto dal demone dell’analogia, della similitudine (…). Questo poeta costituzionalmente incapace di vivere, si era creato un habitat di parole poco o nulla significanti, non tanto espressioni quanto emanazioni del suo ribollente mondo interiore. Certo se scoprissimo la chiave di quell’intrico di rapporti ben altra evidenza assumerebbe una poesia in cui è, sicuramente, «un’idea dell’essere come tremore, terrore, catena di eventi fulminei, rotti, casuali» e sostanzialmente «più una fisiologia che una calligrafia». Nelle sue libere lasse (lontane da quell’alta marea verbale che fu di Whitman e di alcuni futuristi) Calogero scompone in emistichi il nostro verso tradizionale e lo ricompone in nuovi modi, con frequenti ipermetrie e non rare rime, piuttosto acciuffate a volo che necessarie. (…)Egli non scriveva la sua poesia, la viveva in un modo del tutto fisico e per lui l’attesa era qualcosa di inimmaginabile. Se avesse potuto distaccarsi almeno per un attimo dai suoi versi, sarebbe ancora vivo“. Non sono del tutto d’accordo.
Renzo Franzini compone la sua interpretazione con altra postura: non porge un inchiostro assertivo, ma incontra corpo a corpo i versi di Calogero: accosta, motiva, evidenzia, cita e torna alla parola, al verso, con strumenti, riflessioni, sempre puntuali e colte. Indica la necessità di leggere a voce alta, perché la sua scrittura è essenzialmente dipendente dalla materia fonica. Propone non tanto una linearità di sviluppo lirico, ma andamento per eco e risonanza. Anche per quell’incessante sgranulamento, e dissoluzione delle parole che le riconduce alle soglie del silenzio.
Scrive Calogero in una lettera riportata da Amelia Rosselli, nell’attentissimo suo saggio oggi disponibile per consultazione sul sito ufficiale del poeta: Le mie poesie poi, può darsi che siano prive della più elementare importanza come della più elementare analisi logica e grammaticale.
Al contrario, proprio qui sta la grandezza di questo poeta, ancora troppo dimenticato.
Cito alcuni titoli dei capitoli, tanto per significare la qualità dell’analisi di Franzini: Anagrammi, Cenni sulla poetica, Grammatica o della paratassi, Collassi cronologici.
Moltissimi inediti di Lorenzo Calogero aspettano ancora di essere pubblicati. Invito, oltre a incontrare il saggio, a consultare il sito dedicato al poeta calabrese.
Vincenzo Lauria & Liliana Ugolini, Oltre Infinito, La Vita Felice, 2021
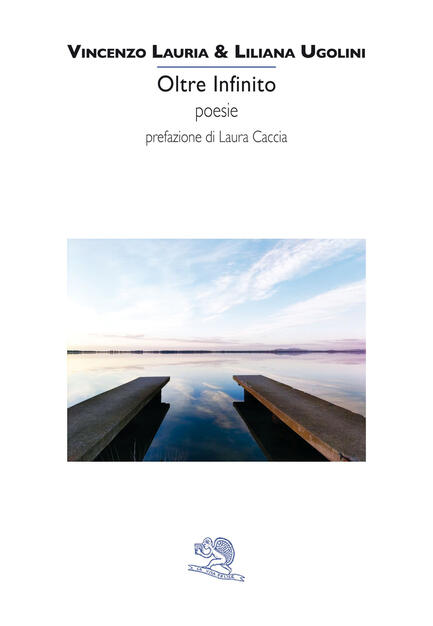
Oltre Infinito è un libro che raccoglie i testi poetici della esperienza di poesia performativa omonima (Oltre Infinito 1, Oltre Infinito 2.0, Ol3 Infinito) che Vincenzo Lauria (VL) e Liliana Ugolini (LU) hanno realizzato in un progetto in cui si uniscono poesia, musica, teatro, cinema, pittura e collage – immagini, video, voce, luci – in un’idea di arte totale che travalichi i compartimenti stagni fra le forme e i generi, “in una totalità allargata e cosmica” (LU). Progetto questo che va apprezzato innanzitutto per lo spirito di condivisione fra autori, che va in contro-tendenza con la naturale pulsione narcisistica di ciascuno: qui le individualità, nel rispetto e nella stima reciproci, si fondono, si integrano e intersecano in un’esperienza poetica comune. Oltre Infinito è anche “manifesto” dell’oltranza: ripudiando la poesia “intimistica” e, dunque, la poesia tutta centrata sull’io, Oltre Infinito è la proposta di una poesia, la cui materia è “scientifica e tecnologica”, privilegiando “contenuti a carattere non autoreferenziale” (VL) e quindi impone all’io di proiettarsi sul mondo, di espandersi verso l’ esterno soggetto / oggetto della poesia – “L’altro è il mio fuori e dentro di noi due / due filastrocche tonde in uroboro” (LU) -, l’Altro come mezzo per riscoprirsi più autenticamente. “La destinazione è l’espansione del circostante / in un perenne non-arrivo a un non-dove finito”: scommessa quindi di un’oltranza che, lungi dal ritenersi perseguibile, deve il suo significato alla ricerca in sé, alla sfida imposta dalla soglia perché “Il margine oltrepassato è terra libera” (VL).
È proprio grazie all’indagine, allo sprofondamento nel magma della nuova realtà tecnologica, informatica e cibernetica, nella realtà virtuale e nel tessuto connettivo delle reti di telecomunicazioni, onde radio e fibre ottiche, grazie a tutto questo – dicevamo – che è possibile prendere coscienza del rischio, sempre più pervasivo, della disumanizzazione, della perdita della dimensione interiore e spirituale dell’uomo, in un processo di alterazione che porta l’uomo verso la sua riduzione meccanicistica, alla prospettiva concreta del cyborg, alla falsificazione come nuovo paradigma di verità (a cui naturalmente ogni poesia, conscia del proprio ruolo etico, come quella dei due autori, non può se non ribellarsi). Ecco allora versi come: “Decostruisco la vista che m’automa” (LU), “Tecnologicamente obsoleta / la trama del vivere si dopa virtualmente” (VL), “con la presente intendo inoltrare autodenuncia / per abusiva costruzione / di una multi-proprietà identitaria / ospitata in una volumetria in perenne espansione” (VL). Alla dimensione di un sapere deterministico, predeterminato secondo uno schema di causa-effetto coercitivo, la strada che si prospetta per contrasto è allora la violazione sistematica del giogo meccanicistico, tramite la sponda di libertà e di associazioni impreviste e imprevedibili offerte dal linguaggio: “dialettiche e allusioni (alluvioni) / di doppi. La verità / del perdersi.” (LU). E poi, in definitiva, tutto questo altro non è se non affidarsi alla lingua dell’arte che da balbettio o lallazione primordiale – “MOCCA / MAMbo / MoMa / MART” (VL) – riscoprendo il proprio alfabeto ipogeo e trasponendolo in voce, in gesto, prende la forma di “habitat” che sa accogliere: “A ogni passo un tuffo ad arte / un filo a piombo / l’Oltre, fuori cornice“ (VL).
“Nell’uso della tecnologia e della digitalizzazione, la capacità di pensiero e la multimedialità dell’Arte possono NON relegarci in un auto / ritratto / automa” (VL): tema questo che si sviluppa emblematicamente in tutto il lavoro e con particolare evidenza in una serie di poesie / autoritratti che sono una sorta di ultima chiamata per la difesa dal disumano, per evitare la riduzione dell’uomo a macchina. “Capelli sono foreste di bulbi / la pelle cambia a strati / e gli occhi son due camere / incrociati.” (LU) , eppure “L’accidente vita è insospettabile / al cenno d’eternità e lo spazio / s’accorcia a un tratto / e il filo appare” (LU): inganno che si palesa in tutta la sua evidenza. Bene sintetizza allora lo spirito del progetto, questo ultimo passaggio che citiamo da “Ausili d’arti”: “persistere nel non cedere / l’intelligenza all’artificiale intelligenza / è salvifico / in un condursi per gradi d’Oltre.” (VL) Messaggio questo che ribadisce quella pratica della poesia come oltranza / oltraggio che in realtà era già in Zanzotto; con Lauria e Ugolini questi procedimenti formali e esistenziali trovano una nuova forma originale, consapevole di tutte le trasformazioni / costrizioni che la nuova società del digitale impone.
Angelo Lumelli, Le poesie, Il Verri edizioni, 2020

Un’opera vivente in tutti i sensi. Introdotta da Eugenio Gazzola con scrittura necessaria, articolata, rispettosa e ammirata, attenta e paziente da cogliere dettagli e complessità dell’originalità magistrale di questo poeta.
Angelo Lumelli nasce il 9 aprile 1943 al confine tra Piemonte e Lombardia, alla Ramata, una località di cinque o sei case nel Comune di Momperone. Trascorre il ginnasio in seminario, In Germania vive il suo essere migrante e studente di Filosofia, Torna in Italia insegnando nelle scuole medie del vercellese, poi si trasferisce a Milano e poi torna a Ramata, gestendo per vent’anni una cooperativa agricola. Collabora con una società di ingegneria specializzata nella programmazione e progettazione.
Milano è stato il luogo più fertile di relazioni nel suo pensiero e nel suo canto: qui nel 1970 crea una rivista e collabora con Michelangelo Coviello e Milo De Angelis, coinvolgendo personalità come Giancarlo Majorino, Antonio Porta, Giovanni Raboni. Viaggia spesso verso Bologna dove incontra Renato Barilli, Guido Guglielmi, Giorgio Celli, e molta critica d’avanguardia, E’ proprio alla metà degli anni Settanta, quando incontra Nanni Cagnone e Luigi Ballerini. Nel 1977, la sua prima pubblicazione Cosa bella cosa per Guanda, dentro cui sono concentrati tutti i temi che lentamente tesserano la sua opera. Vince con questo libro il Premio Viareggio Opera Prima. Da qui un tappeto di opere di poesia e traduzioni, con presenza in antologie e riviste.
Cito dalle prime, necessarie, righe introduttive di Eugenio Gazzola:
Il nuovo libro di Angelo Lumelli è il risultato della riscrittura della sua opera poetica. L’autore ha definito l’operazione una ‘ripronuncia’ che vale come un nuovo dire, un tornare alla voce, a un magico daccapo, e con ciò mandando all’aria una delle poche cose certe della letteratura, il fatidico ‘testo’, quanto di più sacro e intoccabile, allorché, diventato ‘figura’ impone di non essere sfigurato. Invece, un lavoro accurato di scavo, di rimozione, di sostituzione ha investito le pagine del passato – anche di quello recente. Lasciandole nuove. Ha salvato solo il titolo. …Quindi è un libro inedito, ed è un libro della vita.
E’ tessere con il proprio filo della vita un tappeto mai definitivo, proprio per ri agire e reagire e rinascere dal principio. Dichiarare così, vivere così, un’impermanenza relazionale con lo spazio, il tempo, la memoria, i fatti che hanno inciso la cera della nostra esperienza. Una sostanza che troviamo nel viaggio di Lumelli è ciò che lui chiama “la calza rovesciata”. Quel gioco che si fa durante l’infanzia: non solo rimettere a vuoto il contenitore filato, ma averne consapevolezza e riaverlo diversamente, riviverlo. Fa pensare alla tela di penelope interpretata non come continuo atto di cancellazione ma di permanente tessitura. Se il filo che ci è dato è uno e uno solo, e attraverso di lui si può compiere un’opera, un’unica opera, rovesciandola e risorgendola, ci si moltiplica, si intensifica la vita nella propria creatività respiratoria, biologica, artistica. La poesia non è definitiva. Nella sua agitazione fermentante ci porta all’aperto, al plurale di noi stessi e della creazione in sé.
… l’inizio è ininterrotto
(più si ripete più si perfeziona)
L’opera sfocia in coda in La porta girevole dell’Hotel Excelsior, dentro cui Lumelli si avvicina con una parola non meno intensa, toccante e riverberante. Da Johannes Tauler, sec, XIV l’ammonimento “Per amore di Dio, badate alle vostre parole”.
Sempre in una tensione lirica pensante, Lumelli scocca il significato in lucentezza. Propone un sentire e un vivere fisicamente la lingua, la poesia, come sostanza organica, con una potenza al limite della sostenibilità.
Un’immagine, che non posso tacere, mi accompagna: vedo figure di parole che si allontanano, di spalle, per giunta verso occidente, parole femminili, alla lettera, donne parole, in conformità con il loro genere grammaticale.
Non parlano con me. Io le posso soltanto chiamare, una volta sola…
Le mie parole amate non cercano il mio consenso, Non vedo che la loro nuca. Anch’io, confesso, sento la mia nuca, la soglia vuota da cui provengo.
Si può soltanto cominciare da capo, come se la storia fosse un accumulo che non soddisfa i requisiti di purezza?
Come una grandine nutriente Angelo Lumelli crea delle lenti di ingrandimento in interrogativi che ci fanno sporgere nell’abisso: il testo, come ombra della mano? La poesia è l’impronta della scarpetta dell’atleta prima del salto, per cui mai, da quei segni, si potrà sapere se il salto è avvenuto?
L’opera è splendida: lascia ammutolimento per la sua risonanza. Lascia tremanti.
Luisa Delle Vedove, Nella consuetudine del tempo, prefazione di Luigia Sorrentino, Collana Scilla, Samuele Editore, 2021

La poesia di Luisa Delle Vedove è uno scandaglio nell’interiorità, alla ricerca di quelle ragioni interiori che stanno alla base del dialogo fra uomo e tempo, nel tentativo di poter tradurre questa esperienza cognitiva in parola, in verso. Si tratta quindi di una poesia essenzialmente intimistica, tutta concentrata sulla emergenza dell’io, che si interroga a fondo, esplora le zone di buio che si annidano pervicacemente nella nostra interiorità, per portarle alla luce, esporle in forma di versi per chi le vorrà accogliere. Ma questo non comporta nella poesia di Delle Vedove un ripiegamento solipsistico, anzi porta alla comprensione che scaturisce dal dialogo silenzioso con sé stessi, ossia che si è unità in movimento di resistenza con l’intera comunità degli uomini: “moltitudine unita in cammino / mentre la terra frana”. Risiedere “nella consuetudine del tempo”, come recita il titolo della raccolta, non significa allora adeguarsi a un ordine imposto, accettare lo status quo dell’esistenza in tutte le sue implicazioni problematiche, ma interrogarsi sul senso di un percorso nel quale la poesia è una delle strade concrete da attraversare, da percorrere.
Colpisce nella poesia di Delle Vedove la rilevanza che si attribuisce alla memoria e al ricordo (cioè la forma con cui la memoria sa esprimersi), per riportare in emersione il passato che ci appartiene; ma anche saperne svelare la trasformazione, svelarne ogni illusorietà conformistica. La figura della casa, il luogo della intimità domestica e dell’accoglienza, a cui la memoria ci riconduce, il luogo ”della breve / murata infanzia”, diventa allora lo scenario disabitato delle nostre aspettative irrisolte, tutto “blocchi di buio” e cortili in cui “l’erba cresce a dismisura”: la poesia di Delle Vedove diventa così anche poesia che accerta lo spossessamento, il sabotaggio di tutto quanto autenticamente ci appartiene. Ma nessuna desistenza. Rimangono poche certezze a cui coraggiosamente riferirsi, buio e sabbia come residui e macerie di un mondo che ci sarebbe potuto appartenere:
in questa notte disabitata
– in questo luogo –
guardo le luci accese:
non dureranno molto,
il buio qui è più denso
e sulla riva più stretta del giorno
non so quanto di sabbia rimane
Allora il senso del tempo, ben oltre la sua consuetudine che ce ne fa perdere la consistenza pregnante, è questo suo rendersi universalmente presente nel sapersi aggregare e addensare, restituirsi così alla matrice originaria in cui è ancora possibile ascoltare “il primo grido”, quello comune a tutti gli esseri viventi, biologicamente determinati:
perché tutto il tempo forse si compatta
si torna indietro
restituiti
– gesto infinito di silenzio in silenzio –
all’origine
Un altro elemento ricorrente nella poesia di Delle Vedove è il paesaggio, soprattutto naturale, che diventa trasposizione dello stato interiore, traslato di un senso di smarrimento e inquietudine che sbalza dalla pagina, nella consapevolezza che “c’è come un pulsare d’eterno / in questo tacere delle cose”, una lingua sotterranea da far emergere. E l’autrice vi riesce con misura e densità espressiva, in un verso che si impegna “a cercare una vena”, a stanare la “bestia” (suggestione da Caproni) che si annida dentro di noi, per ritrovare il nostro posto dove “qualcosa trascina trascina…”. È lì che opera la poesia.
Paul Vangelisti, My Desert City, Fuoco fuochino, 2020
Le edizioni di Afro Somenzari, splendidamente nominate come fuoco fuochino, hanno il corpo e il volto di una povertà essenziale che in quarta di copertina brilla con una spirale verde stampata da cui sembra uscire una stellina dello stesso colore. Sotto è incollato un francobollo violaceo di una lira, emesso come imposta generale sull’entrata. Dedico attenzione a questi fogli di poesia scelti con vocazione amorosa e qualità, proposti in edizione numerata in undici esemplari più nove per Prove dell’Editore.
A ottobre dell’anno scorso, il fuochino ha portato luce a Paul Vangelisti nella traduzione di Andrea Borsari, con testo a fronte. Tre testi che spiccano in originale libertà di accostamenti, creando movimenti e improvvisi. In una leggerezza onirica che irrompe nel quotidiano, lo disorienta.
Paul Vangelisti è poeta e traduttore. E’ importante ricordare il suo lavoro di traduzione su Amelia Rosselli e Adriano Spatola.
Giancarlo Baroni, Il colore del tempo, Quaderni della Fondazione Daniele Ponchiroli N.5, Patrocinio del Comune di Viadana, in collaborazione con Arti Grafiche Castello, Giugno 2020

Si tratta di un’interessante pubblicazione a tiratura limitata in 250 copie numerate in cui Giancarlo Baroni si propone nella duplice veste di autore di poesie e di fotografo: il libro raccoglie sia sue composizioni in versi sia sue fotografie tutte centrate sul tema dell’arte, pittorica e scultorea in particolare. Assistiamo, volendo essere specifici dal punto di vista tecnico, a ecfrasi che si servono di due strumenti indipendenti, eppure in stretta comunicazione fra di loro: il verso poetico e l’obiettivo fotografico (anche la fotografia è in fondo solo una possibile rappresentazione, se non una rielaborazione, dell’opera riprodotta); il tutto in una realizzazione grafica curatissima, raffinata.
I versi e le fotografie di Giancarlo Baroni ci accompagnano in un viaggio attraverso le opere d’arte dalla antichità e dalla classicità fino all’arte contemporanea, compresa la pop art, la body art e le più recenti espressioni di arte concettuale. A caratterizzare il Baroni poeta è senz’altro la brevità: le composizioni di pochi o pochissimi versi concentrano e addensano il senso, sembrano quasi uno scatto (e non a caso l’autore è anche fotografo) che cerca di dare espressione all’istante, cogliere il valore dell’opera aldilà della sua immediatezza espressiva per cercare di carpire la sua anima profonda: ciò che resta, ciò che dura. L’espressione scarna, asciutta fino alle estreme conseguenze fanno sì che sia l’opera a essere la protagonista assoluta, a esprimersi nella sua compiutezza attraverso la parola poetica; l’autore sceglie consapevolmente di eclissarsi, rendere un servizio all’arte che deve essere la sola protagonista, la sola in evidenza. Ogni tentazione narcisistica viene meno; è la poesia a farsi strada. Ecco allora il celebre Discobolo di Mirone che diventa:
Energia concentrata in un punto
torsione del dorso Bang
esplode l’universo.
O ancora, ecco come si afferma sulla scena il nuovo genio (Leonardo in questo caso) nella poesia sul Verrocchio (e l’angelo dipinto dal giovane Leonardo):
Perché smetto? Pensate
di vedere nel quadro che state dipingendo
un angelo che annuncia
il vostro fallimento.
Discrezione, attenzione al dettaglio, cura e selezione minuta della parola sono elementi che caratterizzano la cifra stilistica di Giancarlo Baroni, in continuità con il suo percorso poetico così coerente, passo dopo passo. In questo lavoro la sua sensibilità e il suo occhio attento sul mondo, alle sue espressioni di bellezza, trovano un’ulteriore conferma, in un lavoro misurato e incisivo insieme, un lavoro che sa combinare la concisione con la capillarità pregnante e allusiva del dire poetico.
Cartoline per Alberto

Mostra, casa di Rigoletto, maggio 2021
Cartoline per Alberto è una pubblicazione quadrata che contiene storia di amicizia. Raccoglie cartoline che riguardano la vita di Alberto Cappi, la sua corrispondenza con poeti, con artisti, amici. Alberto usava le cartoline che comprava, che commissionava a chi aveva l’occasione di viaggiare, che arrivavano anche casualmente nelle sue mani, per spedire pensieri, cenni, saluti. I destinatari rispondevano, inventavano segni, giocavano con quel rettangolino di carta, restituendo colori.
A dieci anni dalla morte di Alberto, Italo Lanfredini ha voluto rintracciarle, chiedendo un ritorno, una sorta di provvisoria restituzione; ne ha raccolte in grande quantità e ha voluto metterle in mostra.
Nel 2019, nel Palazzo Ducale di Revere, ha allestito, in una grande sala, una lunga distesa di cartoline, appese a un filo sostenuto, nel sinuoso percorso, da piantane di gesso e legno, costruite con le mani, le sue di artista. Tre momenti scandiscono la mostra: le cartoline inviate da Alberto, con le sue parole, lo scherzo, la poesia, l’affetto. Poi le cartoline mandate dagli artisti, molte delle quali con diretti interventi sulla patinatura del cartoncino. Una fila lunghissima di nomi e segni, immagini e frammenti poetici, saluti e versi di delicata fattura. E ancora una parte dedicata ai bambini che hanno creato le cartoline con Italo, bambini delle scuole elementari di Revere e Ostiglia, indaffarati con il Maestro intorno ai versi di Alberto, divertiti in questo gioco del fare e del rispettare, rispettare un contorno, rispettare un’idea, rispettare le regole dell’affrancatura e del timbro postali. Artisti di Mail Art.
Ora la mostra, dopo il lungo tempo delle distanze e delle separazioni, è approdata alla Casa di Rigoletto, a Mantova, a cura di Italo Lanfredini e Raffaella Molinari Cappi, con l’organizzazione dell’Associazione La Corte dei Poeti. Qui il terzo momento della mostra prende un rilievo speciale e diventa la stanza dello scambio di cartoline tra Alberto Cappi e Italo Lanfredini, la storia di un legame d’amicizia, che riesce a dirsi, con la parola o con il tratto di colore, che incanta chi si avvicina e legge su questa esposizione, ad altezza di occhi. “Il tempo, caro Italo? Un trastullo per gli dei, direbbe Eraclito. Quella di Giacometti, sarà forse una stele di Rosetta del corso dell’arte? Nel tempo, la parola pulsa tra eco e silenzio. Ciao, Alberto”. Tutto quello che sta in una mezza cartolina, lo spazio destinato ai saluti, diventa un universo, una cornucopia di evocazioni, un mettere in fila gli dei, il tempo, il silenzio, la storia, la parola… E la risposta degli amici arriva puntuale: la cartolina Amore di Giuliano Della Casa, il progetto di una mostra da Massimo Mori, due versi di Marco Munaro…
Le cartoline si muovono sui fili, come panni stesi in lunga teoria, e si lasciano guardare su entrambi i lati, esposte, fruibili, ammiccanti nella loro precarietà: hanno trovato sosta per un pensiero e sono volate a un destinatario, affidate ai sacchi della posta, a volte ammaccate, piegate o intatte, lasciate liberamente al tempo di un viaggio.
Maria Lenti, Elena, Ecuba e le altre, prefazione di Alessandra Pigliaru, Arcipelago Itaca, 2019

È un viaggio attraverso il mito della Grecia classica quello che ci viene proposto da Maria Lenti, tutto declinato all’insegna delle figure femminili e quindi, in definitiva, un’esplorazione dell’archetipo femminino così come viene proposto da questa tradizione. Le poesie, tutte in prima persona, vedono le donne del mito rivolgersi all’uomo per dare voce alle loro vicende, illustrarne le ragioni, coniugarne il senso, il tutto con un rigore e una compostezza del linguaggio che sono vicini alla lezione della classicità, ma con una sensibilità tutta moderna; l’obiettivo è cogliere in queste figure il contemporaneo, quanto di loro sia ancora affine e quindi possa ancora parlare all’uomo e alla donna di oggi, riattualizzare la lezione del mito in una prospettiva di valori e di situazioni attuali. Ecco allora Penelope dire, ad esempio: “non simulo mal di testa / né tela di lino da finire. / In me necessità di ricapare / l’ordito dell’assenza”.
La raccolta ha una compattezza dettata sia dalla organicità del tema sia dalla coerenza dello stile che punta a una parola asciutta, mai esornativa; la dizione è netta, in poesie che sono brevi o brevissime; pochi versi in cui si concentra la storia di una vita.
Questo lavoro di Maria Lenti non vuole però essere, per quanto colto, un esercizio letterario, un confronto puro e semplice sul piano letterario con la mitologia, ma è innanzitutto poesia dell’impegno, come tutta la storia di Maria Lenti sia come scrittrice sia come attivista in campo politico e sociale confermano. Il mito è lo strumento con cui mettere a nudo, o denunciare, quanto ancora manchi rispetto al conseguimento di quella reale e oggettiva identità di genere che è uno dei temi fondamentali della nostra società: la donna non può essere solo “metafora”, figura che viene rappresentata con l’occhio (e spesso il pregiudizio) dell’uomo; la sua storia va riscritta, va rimodulata in accordo alla sensibilità che le è propria. Questa poesia del mito, questa sua riscrittura è allora innanzitutto un atto di civiltà, di verità. La voce con cui parlano queste donne del mito è anche voce di ribellione, di rivalsa, di restituzione dei fatti e dei valori alla loro matrice più autentica. “Salva, leva di dosso la tradizione” dice Dirce ai contemporanei; una per tutte. E ancora Antigone che, giustamente, rivendica lo spazio che va concesso alla legge del cuore, quella che ci insegnano le donne, mentre l’uomo sa affidarsi solo allo ius legis, incapace, da solo, di esprimere la pietà, la comprensione, l’accoglienza. Il mito diventa, grazie a Maria Lenti, attualità, parola che resiste, che chiede giustizia, come in “Filomela a Tereo”:
L’abuso e il taglio della lingua,
ma ho dita per ricamare
e il messaggio giunge alla sorella.
Che credevi, Tereo,
di avermi ridotta a tacere la violenza?
Un libro inattuale e al tempo stesso di cocente attualità, questo di Maria Lenti, raccolta di voci che si fanno coro, grido, canto unanime da ascoltare e accogliere.
Luca Pizzolitto, La ragione della polvere, peQuod, Ancona 2020

La polvere sa essere estremamente convincente, la sua ragione ha fatto riflettere dall’inizio dei tempi migliaia di uomini e migliaia di poeti ne hanno scritto nel corso dei secoli. La polvere ha sempre l’ultima parola, resta e si impadronisce delle case e degli oggetti quando i loro proprietari non ci sono più. A lei dedica le sue parole versificate anche Pizzolitto, in riflessioni esistenziali, poste con cura e perizia al di fuori del tempo. La caducità della vita, l’impermanenza della felicità, l’istante che riempie di meraviglia, che illude sulla sua possibile continuazione e poi si perde inevitabilmente nel rivolo dell’esistenza: questo l’assunto entro cui si muove la poesia di Pizzolitto.
Ho un Buddha nella posizione indicata come Bhumisparsha Mudra, su un tavolo rotondo cinese: ha dei lustrini sulla veste dorata che per un minuto al giorno, di pomeriggio, a seconda di come gira il sole, proiettano sui muri circostanti piccoli dischi di luce colorata. Per un minuto. Dopo questo momento glorioso torna l’ombra, la meditazione, l’oggettualità. Ma in quel minuto tutto sembra cantare. Così anche l’autore distende panorami di gravità ed enigmi la cui sicurezza ci ha sempre sconcertato, per contrapporre una breve pennellata di colore e di soavità:
Qualcosa resta in silenzio
e rimane nascosto
nel niente senza stelle
che ti riempie e consuma.
Anche in me attende
il vuoto straziante di Dio,
e questa ignobile,
mai sazia inquietudine.
Le api tracciano geometrie gioiose
tra i fiori di pesco e il cielo.
(Geometrie, p.10, vv. 1-10)
Questa poesia che medita sul mistero oscuro del nostro essere al mondo e dei sollievi istantanei che può offrire la natura intorno o una predisposizione effimera dell’anima, ha ascendenze remote, la Bibbia del Libro di Giobbe e l’Ecclesiaste, i mistici mussulmani, il grande poeta persiano Omar Khayyam che cantava lo stordimento come unica possibilità di sfuggire all’arbitrio del destino e al tiro di dadi di Dio. Emily Dickinson, naturalmente. In Italia questa lacerazione fra il dolore inesplicabile e certo della condizione umana e l’aspirazione alla consolazione dell’amore in purezza carnale, ha un suo forte testimone in Giovanni Testori.
Le parole in questo contesto non sono scelte come segno arbitrario, diversamente interpretabile dal lettore, ma circoscrivono un’esperienza comune e sono essenziali come una sentenza.
Stupende sono queste grida
che smembrano la notte,
stupendo è tutto ciò che sopravvive
all’affanno scarno delle cose,
la luce austera del mese di marzo,
nel niente colmo di misericordia
di un nuovo, disperato silenzio.
Dura un istante questa misera gioia.
(Dura un istante, p.13)
Anche il repertorio metaforico scelto dell’autore attinge a un repertorio in cui ciascuno di noi può riconoscersi. Sia che ci si accosti al mistero con spirito religioso o laico, resta comunque un paradigma di immagini che unisce la sensibilità della tradizione giudaica cristiana a quella orientale.
Io sono la foglia piegata
dalla brezza leggera,
io sono il sale sulla ferita,
io sono questo affannato correre
e morire.
La quiete di un istante,
nell’accadere del nulla.
(p.27)
Interessante è capire se i grani del rosario si snodano fra le dita sempre uguali oppure se questa smisurata invocazione, abbia un’evoluzione tra le sue varie parti. L’ora scandita è sempre la stessa, sempre questa misura mai colmata di pazienza da opporre all’assenza di un senso, oppure c’è in questa poesia un passaggio dall’ombra alla luce, dalla notte al giorno?
Nei silenzi impossibili
nella bianca innocenza
di una preghiera sussurrata.
Tutto è instabile e arde,
arde d’amore.
Tutto cade inesorabile
e si fa nostalgia.
(p.47)
Il libro ha varie sezioni, “Spasmi”, “Noi che abbiamo perso la fame”, “Dal profondo”, “Benedizioni” che contrappongono fin dai titoli questa polarità incessante fra l’angoscia e la trafittura del sole che ci ci inebria nonostante la sofferenza del nostro esserci. Ma è l’ultima sezione che insiste maggiormente sulla necessità di riconoscere nelle ferite dell’altro le proprie e nell’aprirsi dunque allo spirito della comprensione e della compassione. Fra tutte le figure create da Dostoevskij, una mi è particolarmente cara ed è quella tratteggiata nella figura del principe Miškyn, nel romanzo “L’idiota”. L’ultima sezione titolata da Pizzolitto PREKRASNYJ (LO SPLENDORE DELLA BELLEZZA), proprio questo personaggio richiama come orizzonte ultimo di riflessione e di possibile azione. In una sua lettera il grande scrittore russo, a proposito del suo progetto, usa questo termine per indicare l’uomo ‘assolutamente buono’ che dovrebbe essere protagonista del suo romanzo. Il modello cristologico di cui parla Dostoevskij è una declinazione dell’idea dell’uomo virtuoso e bello della Grecia classica, in cui il dettame dell’armonia è stato incrinato dalla coscienza del dolore, ma questa incrinatura piuttosto che una limitazione, è un ampliamento che irradia appunto ulteriore bellezza. Ma la vocazione estrema di ad aprirsi a tutto il dolore degli uomini e a glorificarlo attraverso la sua condivisione, non può essere visto dagli altri che come follia. Ancora oggi, mentre le immagini della contemporaneità si uniscono a quelle di una fede che pare trascorsa, lo scandalo resta aperto, aperta resta la frattura tra l’io e il tu che ci chiama da un luogo diverso dal nostro, radicalmente diverso dalle nostre abitudini.
I panni stesi al sole ad asciugare,
il cane che dorme sul tappeto
comprato ieri su ebay,
il ramo d’ulivo appoggiato all’icona
di un Cristo scalzo e bambino:
questi silenzi che, nell’attesa,
si fanno volto e preghiera.
Tu provieni dal niente lontano.
(p.117)


Due emozioni su “Cartoline per Alberto”. Alla seconda (o terza) pagina del libretto – che non è un catalogo, ma un piccolo scrigno di amicizie, di affetti che non demordono, anzi si sostanziano del tempo, acutizzando il senso di ciò che non può essere cancellato semplicemente perché c’è stato ed è stato tanto forte da gettare continuamente in polloni nuovi e fruttiferi – c’è una magnifica fotografia di Alberto – grazie e grazie a chi l’ha proposta e scelta! – capace da sola di dirlo, lui, Alberto: al centro di una piazza assolata, quasi deserta, dove le ombre si stagliano forti, quindi forte è il sole e quindi il caldo, Alberto, con le mani sui fianchi, i gomiti larghi -pare che anche le braccia farebbero caldo se aderissero al corpo -, gli occhiali da sole, in testa – proprio in testa – nessun cappello, ma un bel libro, aperto a metà e posato a tetto del suo capo. Ecco lì, è proprio lui. Nient’altro potrebbe difendere i suoi pensieri, le sue riflessioni, gli incipit di un suo verso se non un libro. E, nel frattempo, cosa sarebbe un libro, anche pieno di sublimi parole, se non fosse capace di stare dentro il mondo, di toccare la materia, la carne, la testa di un poeta? Ben venga questo ricordarlo – no, riviverlo- con cartoline che potrebbero comporre un libro, libro vero come quello che ha in testa, perché erano/sono cartoline di concreti rapporti, concreto progettare, fare, concreti affetti, anche concrete arrabbiature ed ironie, ma erano/sono spesso – o sempre? – qualcosa più in là, domande lanciate come razzi d’avvistamento, intuizioni fulminee, versi autentici di poesia. Alberto è un grande poeta, e come tale io invito a leggerlo e pensarlo e trattenerlo, perché la grande poesia non va fuori moda col tempo o con la morte. Ma era anche una bella persona. E come tale ci ha arricchito tutti della specie. Godiamone, di questa ricchezza.